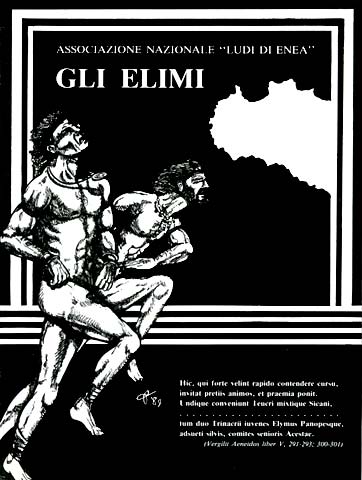|
| Valle dei Templi |
Sono molte le implicazioni simboliche della Mandorla tra le quali la più diffusa è quella dell’iconografia tradizionale medievale. All’inizio del secolo scorso la provincia di Agrigento era il primo produttore mondiale e la mandorla rappresentava la principale fonte di reddito. Di questo frutto nulla veniva perduto: la legna della potatura serviva ad alimentare i forni per la cottura del pane, con il mallo esterno si lavorava un tipo di sapone molle chiamato "scibina", il guscio veniva utilizzato per alimentare i bracieri in casa. Agrigento non detiene più questo primato che tuttavia si sta cercando di recuperare. In primavera si svolge in questa città la sagra del "mandorlo in fiore che ricopre la Valle dei templi di un delicato manto bianco e rosa simile a quello di una sposa che annuncia la primavera. (A proposito di spose, sembrerà strano ma le mandorle sono molto utilizzate anche nella cucina dei Paesi settentrionali dell'Europa e in Svezia sono protagoniste di una tradizione molto simpatica. Alla vigilia di Natale si prepara un dolce di riso all'interno del quale viene nascosta una mandorla. La persona che la trova sarà la prima a sposarsi).
I DOLCI ALLE MANDORLE
Tutti i dolci che si preparano rimandano al mondo arabo e alle origini asiatiche della mandorla. Le mandorle amare contengono acido prussico (acido cianitrico prodotto dall’amigdalina) e non vanno dunque consumate in grande quantità. L’utilizzo della mandorla per la preparazione di dolci è molto vasto, ogni provincia o, addirittura, ogni città utilizza questo squisito frutto per la realizzazione di piatti tipici. Il Marzapane o Pasta Reale è, realmente, il principe tra dolci di mandorla. Si prepara con farina di mandorle o, in alternativa, con mandorle non tostare e frullate, e zucchero a velo in parti uguali. All’impasto viene data generalmente la forma di frutta o verdura utilizzando dei coloranti par alimenti (mandarini, fichi, ciliegie, pomodori, mele, uva, pesche, banane ...). Una tra le bevande più dissetanti preparata con le mandorle, oltre all'orzata, è il latte di mandorla, una bibita dissetante utilizzata soprattutto nelle caldi estate dei Paesi Mediterranei e, contemporaneamente molto energetica,lo sciroppo va servito allungato con acqua freschissima. Con il latte di mandorla si prepara anche la granita di mandorla, tipica prelibatezza siciliana della quale si può gustare anche la variante alla mandorle tostate.